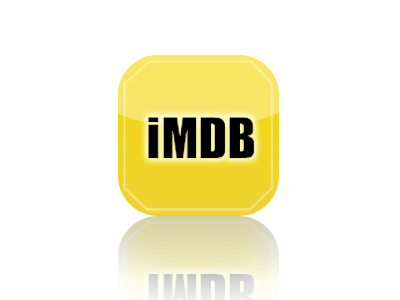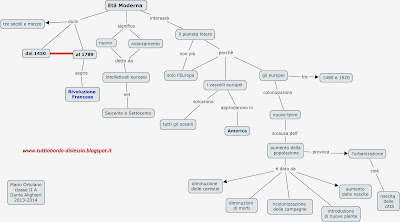Questa è la scheda consegnata dalla delegazione di esponenti delle associazioni ambientaliste Italia Nostra, Assotuscania, Forum Ambientalista, Legambiente e Gruppo d’Intervento Giuridico onlus alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel corso di un incontro tenutosi il 3 giugno 2019 in merito al progetto” di realizzazione di un “Impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 150 MWp connesso alla RTN”, proposto dalla società energetica romana DCS s.r.l., in località Pian di Vico, nel Comune di Tuscania (VT).
Speculazione energetica avverso la quale è in corso una dura e difficile battaglia ecologista.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
MEGA IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA NELLA TUSCIA PIAN DI VICO – TUSCANIA
PREMESSA
Il caso di Pian di Vico e della Tuscia in generale è emblematico e rappresentativo della circostanza che vaste porzioni territoriali classificate agricole possono essere sacrificate ad una progettazione di notevole impatto sul territorio legittimata da una sostanziale carenza normativa.
Le zone interessate (San Giuliano, Formicone, Formiconcino) hanno infatti una particolare valenza sia di carattere storico archeologico-monumentale come descritto nel dossier che segue, sia per la tutela della biodiversità essendo siti storici di nidificazione dell’Albanella minore, specie di particolare interesse comunitario.
La norma derogatoria dettata dall’art. 12, settimo comma, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, introdotta per consentire in via eccezionale la costruzione in zona agricola di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che, per loro natura, sarebbero incompatibili con la predetta destinazione, non riceve nell’attuale sistema normativo adeguato contemperamento con l’esigenza di sottrarre all’insediamento di impianti di considerevoli dimensioni porzioni di territorio agricolo che meritino particolari attenzioni per la loro specificità o perché connesse alle tradizioni agroalimentari locali, alla biodiversità, al patrimonio culturale e al paesaggio.
La limitazione del consumo di suolo ed il riutilizzo di aree degradate, così come una progettazione legata alle specificità dell’area in cui realizzare l’intervento, rimangono dichiarazioni di principio della normativa statale e negli stessi termini vengono recepite in quella regionale. Tali obiettivi sono peraltro ulteriormente minimizzati dai criteri indicati dal D.M. 10 settembre 2010, nel quale si pongono limitazioni di carattere generale alla individuazione da parte delle regioni dei siti non idonei alla installazione degli impianti, con particolare riferimento alle aree agricole (v. paragrafo 17 e Allegato 3).
L’obiettivo di conciliare le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili assegnata (burden sharing) si traduce di fatto nell’attribuire alle programmazioni regionali una funzione meramente ricognitiva dei vincoli esistenti, oggetto di valutazione nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico (v. PER Lazio del 2017).
Al di fuori delle aree considerate critiche, sensibili e/o vulnerabili, comunque ricadenti nella fattispecie già oggetto di tutela (beni ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico, aree protette, siti inclusi nella rete Natura 2000, etc.) la normativa statale e regionale non prevede strumenti efficaci finalizzati alla salvaguardia di tali porzioni territoriali che costituiscono una componente fondamentale del paesaggio direttamente tutelato dall’art. 9, comma 2, della Costituzione, e dalla Convenzione europea del paesaggio.

DOSSIER 2019
Alle porte della cittadina d’arte di Tuscania (Vt), nella località di Pian di Vico (situata in direzione di Montalto), nel mese di Febbraio del 2019 è stato autorizzata la costruzione di un imponente impianto fotovoltaico a terra di 150 MW, progettato dalla DCS Srl, il quale andrebbe a ricoprire un’area estesa su circa 246 ettari.
La zona interessata è caratterizzata dal tradizionale paesaggio della rotazione colturale (soprattutto produzione di cereali, ortaggi, foraggio, pascolo ovino), pressoché integro, nel quale è perfettamente leggibile la successione storica degli insediamenti e degli utilizzi del territorio, nella quale spiccano le seguenti fasi: boschiva a querceto e sughera, principale rifugio della fauna locale che si sposta lungo tragitti di coltivi e di pascoli che verrebbero deturpati o sostituiti proprio dalla presenza fisica degli impianti fotovoltaici a terra con e delle loro strutture e recinzioni industriali. Affacciato sul mare distante e la Maremma, un intero paesaggio antico (grotta Caprara e Pian di Vico) sul tracciato della Via Clodia (secondo Montuori), tra i più belli del centro Italia, verrebbe sostituito dall’impianto fotovoltaico. Un’opera di quelle dimensioni è per essenza immitigabile visto che sostituisce il paesaggio in oggetto.
- l’incastellamento medievale, con la torre di Castel d’Arunto affacciata sui terreni dell’impianto;
- il latifondo dello Stato Pontificio, con il borgo rurale di origine settecentesca di Pian di Vico, da cui il toponimo, che verrebbe essenzialmente circondato da pannelli fotovoltaici;
- l’appoderamento della riforma agraria e delle bonifiche degli anni Cinquanta del Novecento; interessanti episodi moderni sono anche due tabacchifici storici nei vicini pressi del perimetro dell’impianto.
Vanno sottolineati anche il valore produttivo del pianoro dove si ubica l’impianto, irriguo e completamente dedito alle attività agricole, nonché quello naturalistico, dato che il pianoro è delimitato a Est e Ovest da due fossi con corsi d’acqua e rispettive fasce boschive. A nord-est del pianoro, al confine del progettato impianto, vi è un’ampia area boschiva a querceto e sughera, principale rifugio della fauna locale che si sposta lungo tragitti di coltivi e di pascoli che verrebbero deturpati o sostituiti proprio dalla presenza fisica degli impianti fotovoltaici a terra con e delle loro strutture e recinzioni industriali. Affacciato sul mare distante e la Maremma, un intero paesaggio antico (grotta Caprara e Pian di Vico) sul tracciato della Via Clodia (secondo Montuori), tra i più belli del centro Italia, verrebbe sostituito dall’impianto fotovoltaico. Un’opera di quelle dimensioni è per essenza immitigabile visto che sostituisce il paesaggio in oggetto.
IL PAESAGGIO DI PIAN DI VICO, FORMICONE E SAN GIULIANO
L’area che si estende fra il Pian di Vico e le località contermini, anch’esse sedi di antichi latifondi che traggono il toponimo (Formicone e San Giuliano) dai relativi insediamenti storici, è una delle più interessanti del Comune di Tuscania.
La zona di Pian di Vico, Formicone e San Giuliano, in cui si alternano aree pianeggianti e collinari, è caratterizzata da ampi spazi rurali aperti verso il mare, dove si collocano le testimonianze storiche: nel complesso conserva integri tutti i tipici elementi paesaggistici della campagna laziale e in generale della sua evoluzione attraverso le epoche, tanto che non solo è riconosciuto come paesaggio di valore “identitario” per il Lazio, ma è anche stato catalogato nell’ultimo Ptpr (ancora in fase di approvazione), come “Paesaggio agrario di notevole valore”.
Oggi questo paesaggio esprime tutta la produttività agro-silvo-pastorale unita ai valori estetici e potenzialmente turistici di una campagna dall’elevata naturalità.
Tuttavia quest’area, di circa 62 kmq, corrispondente al 29,7 % del territorio comunale di Tuscania, è rimasta esclusa da una recente delibera che sembrerebbe invece tutelare dagli impianti energetici il resto della zona del Comune. Ricordiamo che i megaimpianti di più di qualche ettaro sono per essenza immitigabili perché sostituiscono un paesaggio che sarebbe altrimenti disponibile alla contemplazione.

L’ITER AUTORIZZATIVO DELL’IMPIANTO DI PIAN DI VICO
Il progetto della DCS per Pian di Vico ha ricevuto recentemente una VIA Positiva dalla Regione Lazio ed è stato autorizzato anche dal Comune di Tuscania in fase di conferenza dei serviziTuttavia il progetto ha riscontrato il parere negativo del Mibac che, tramite la Soprintendenza all’Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell’Area metropolitana di Roma, Provincia di Viterbo ed Etruria Meridionale (4 febbraio 2019), lo ritiene “non compatibile con il contesto di riferimento, per estensione, tipo, materiali”, e “non compatibile con la tutela del territorio dal punto di vista paesaggistico e agricolo”. Tale conclusione è stata trasmessa, oltre alla società proponente, anche alla Regione Lazio e al Comune di Tuscania.
Hanno infine espresso posizione contraria al progetto fotovoltaico di Pian di Vico, e in generale a questo tipo di impianti, anche:
- Coldiretti (cfr. http://www.tusciaweb.eu/2018/12/no-al-fotovoltaico-nelle-aree-agricoleproduttive/).
- Lipu (cfr. http://www.viterbonews24.it/news/fotovoltaico-selvaggio-in-provincia-diviterbo_92261.htm).
- Gruppo di Intervento Giuridico
(cfr. https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2019/02/04/lo-scempio-annunciato-dellatuscia/).
- L’associazione locale Assotuscania (cfr. http://www.assotuscania.it/) .
- Italia Nostra Onlus (Italia Nostra – audizione Regione Lazio)

PIAN DI VICO: SOLO LA PUNTA DI UN ICEBERG
Il progetto di Pian di Vico di Tuscania, nonostante sia è quello il cui iter autorizzativo appare in fase più avanzata, non è tuttavia l’unico: infatti, sul sito web della Regione Lazio compare una lunga lista di progetti per mega impianti fotovoltaici destinati alla medesima zona compresa fra Tuscania e Montalto di Castro.
Dal protocollo regionale (in data 19-2-2019) i progetti presentati e sottoposti alla procedura di via:
- Tuscania 150,00 MW – DCS srl
- Montalto di Castro 90,00 MW – CFR srl
- Tuscania 17,28 MW – Limes I srl
- Tuscania 21,59 MW – Limes II srl
- Montalto di Castro 54,20 MW – Camposcala srl
- Tuscania 70,00 MW – Solar Italy I srl
- Tuscania 82,00 MW – Solar Italy II srl
- Montalto di Castro 112,00 Solar Italy III srl
- Montalto di Castro 113,50 Solar Italy IV srl
- Tessennano (VT.Loc. Macchione), 20,160 MWp LIMES 10 SRL
- Tessennano (VT Loc. Riserva), 35,424 MWp, LIMES 15 SRL
TOTALE: 11 progetti – 710,48 MW = 1200 ettari = 12 kmq = 120.000.000 di mq.
Altri progetti sono stati presentati a Viterbo, nei pressi del sito archeologico di Castel d’Asso, a Canino e a Tarquinia. A questi vanno aggiunti gli impianti di
- Tessennano (VT Loc. Macchione), 20,160 MWp, LIMES 10 SRL
- Viterbo (località Cipollaretta- confine est di Tuscania), 81,9 MWp , CFR SRL
Ora moltiplicando per i MW impegnati il valore di 1MW prodotto = 1,65 Ha di terreno occupato, si hanno circa 95 ettari totali per Tessennano e ben 135 ettari al confine tra Tuscania e Viterbo per l’impianto della CFR SRL.
Quindi altri 230 ettari da sommare ai 1200 ettari già registrati!
Si configura quindi una vera e propria repentina metamorfosi dell’intero territorio della Maremma Viterbese, da agricolo a industriale. Chiaramente, le radicali e rapide trasformazioni di un’area tanto vasta non evitano il presentarsi di serie ripercussioni in ambito non solo economico ma anche sociale.
Ma in primo luogo, di fronte ad una serie di progetti la cui realizzazione comporterebbe trasformazioni di tale entità, mancano un’adeguata informazione e i dovuti dibattiti pubblici che coinvolgano la popolazione residente e quella che ha investito nelle vocazioni naturali e consolidate di questo territorio, il cui assetto economico e sociale all’oggi si basa sull’intreccio fra agricoltura e attività turistiche e culturali.
Se dunque la totale e drastica alterazione del territorio di Tuscania e dell’intera Maremma Viterbese dovesse realizzarsi, ingenti ed irreparabili sarebbero i danni a chi ha (spesso già da molti anni) investito nelle risorse, nelle vocazioni tradizionali, nel pregio – dato dalla presenza di siti come Vulci o dalla stessa Tuscania – e nell’integrità del contesto paesaggistico, annualmente celebrato da numerose istituzioni che affermano di voler tutelare e promuovere – e non improvvisamente cancellare – queste stesse vocazioni.
Mentre dunque il fotovoltaico potrebbe essere realizzato in superfici e contesti più utili, sostenibili e vantaggiosi, è viceversa chiaro che Vulci, il centro storico di Tuscania e i loro paesaggi non possono essere semplicemente spostati altrove, essendo essi beni unici e non riproducibili della Nazione che, di conseguenza, come prescritto dall’Art. 9 della Costituzione italiana, abbiamo il dovere di conservare per le generazioni presenti e future.

CRITICITÀ DEL FOTOVOLTAICO A TERRA
In vista di progetti della portata di quello di Pian di Vico è opportuno riflettere sulle criticità ormai rilevate nel corso degli ultimi dieci anni da una sempre più folta letteratura scientifica che invita alla prudenza prima di lanciarsi in una politica di consumo di suolo massiccia. L’impatto globale sui ecosistemi e la biodiversità nonché il clima delle politiche attuali basate sulla crescita. Vista che la Commissione Europea si propone di istituire una politica mirata per garantire la difesa del suolo nella sua globalità,1 di promuovere la salvaguardia del paesaggio2, di porre fine alla perdita di biodiversità3 e si propone di tutelare la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche4. Visto che considera il suolo una risorse sostanzialmente non rinnovabile5, e la sicurezza alimentare6 una preoccupazione, è legittimo chiedersi se è opportuno precipitarsi su una politica di consumo di suolo senza precedenti in una delle ultime zone rurale non montane d’Italia preservate dallo sprawl urbano – grandi spazi naturali e rurali non tramortiti. Una serie di articoli scientifici sulle criticità del fotovoltaico a terra è disponibile al seguente collegamento: http://www.exploretuscia.com/il–fotovoltaico–a–terra–una–pratica–sostenibile–articoli–scientifici/
Alcuni problemi, più ovvi di altri, sono già oggetto di dibattito, come ad esempio:
- la cancellazione del paesaggio rurale e degli ecosistemi connessi; potenziali danni alla biodiversità;
- lo stravolgimento degli elementi sociali, identitari-percettivi ed economici del territorio;
- l’attuale confusione normativa circa le responsabilità dello smantellamento degli impianti e dello smaltimento dei pannelli a fine regime nonché del ripristino dello status quo ante sui terreni interessati.
Vanno poi dettagliate le seguenti ulteriori criticità, che descriviamo qui di seguito.
Consumo di suolo
“Consumo di suolo, Tuscia in testa. Viterbo è infatti la provincia dove nel 2017 la percentuale di terra passata al cemento, e non solo, è cresciuta più di tutte a livello nazionale. Un secco +0,91%. A seguire, Verona (+0,71%), Vicenza (+0,67%), Bolzano (+0,65%), Venezia (+0,57%), Vercelli (+0,54%) e Treviso (+0,49%).”
Lo dice l’Ispra, l’istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nel rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici 2018“, pubblicato assieme al Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente.
Il caso di Montalto.
“Il comune di Montalto di Castro, nel 2016 al primo posto. Ai vertici della classifica pure l’anno scorso con un incremento di quasi 63 ettari. Nel periodo precedente erano stati 65.
“In questo caso – sottolinea il rapporto – la responsabilità è in gran parte delle nuove installazioni fotovoltaiche che hanno coperto aree precedentemente agricole”.
L’Ispra, sempre a proposito di Montalto, dice anche come i campi fotovoltaici siano “già diffusamente presenti per interventi realizzati negli anni precedenti”. Impianti, conclude l’istituto, “che hanno sottratto all’agricoltura enormi superfici”.
Tredici impianti che coprono una superficie complessiva di circa 5 km2 di terreno sono effettivamente disseminati su una superficie di 55km2. Dunque possiamo stimare un fattore superficie di sprawl energetico mediamente dieci volte superiore alla superficie effettivamente occupata. 55Km2 di sprawl energetico in pochissimi anni. Questo sarà il destino del comune di Tuscania che verrà uno sprawl energetico pari a praticamente 100km2 per 10km2 effettivamente occupati dai pannelli.
(cfr. http://www.tusciaweb.eu/2018/12/consumo–suolo–la–tuscia–cima–alla–classifica–nazionale/).
Altri potenziali fattori critici la cui portata è tuttora scarsamente documentata :
- alterazioni dei microclimi locali
- effetti sul ciclo del carbonio
- impatti importanti sull’avifauna
- impatti ambientali legati alla produzione/smaltimento dei pannelli
- impronta CO2 effettiva e EROEI
- improbabilità del ripristino dei luoghi allo stato anteriore dopo il tempo della concessione per i seguenti motivi: costi alti, movimento terra superiori a 5 centimetri difficilmente ripristinati, strade bianche e aree di cemento armato -perdita di biodiversità
- tempi di rigenerazione del suolo fertile e della biodiversità lunghissimi (il suolo come risorsa limitata)
Per approfondimenti rimandiamo al seguente collegamento
http://www.exploretuscia.com/il-fotovoltaico-a-terra-una-pratica-sostenibile-articoli-scientifici/
3- Necessità di massimizzare le installazioni fotovoltaiche sulle coperture degli edifici
“Su Energia 4.18, GB Zorzoli [ingegnere e docente italiano, classe 1932, esperto in energia nucleare e in fonti energetiche rinnovabili, membro dell’Associazione Italiana Economisti dell’Energia, NDR] disegna una strategia per raggiungere l’obiettivo riducendo al minimo i nuovi impianti fotovoltaici a terra. […]
Vanno inoltre massimizzate le installazioni fotovoltaiche sulle coperture di edifici, così da realizzare l’impianto là dove è ubicata la domanda, evitando che una parte eccessiva della generazione fotovoltaica sia installata nel Centro-Sud (dove l’irraggiamento solare è maggiore) e che l’accresciuta distanza dal baricentro dei consumi aumenti i costi per il potenziamento della rete di trasmissione. Vanno inoltre massimizzate le installazioni fotovoltaiche sulle coperture industriali, commerciali, infrastrutturali e delle abitazioni […]
Anche se in Italia non si dispone di una mappatura completa e affidabile dei siti non altrimenti utilizzati, esistono stime relative ad aree industriali dismesse (circa 13.000 ettari), alle cave abbandonate (5.000-10.000 ettari) […]”
CONCLUSIONI
Ricordiamo che – richiamando ancora i dati Ispra – la Provincia di Viterbo ha già subìto un enorme impoverimento ambientale e paesaggistico su tutto il territorio provinciale a causa del fotovoltaico a terra, delle centinaia di ettari già installati a partire dal 2009, senza contare gli impianti eolici da decine di aerogeneratori installati nei Comuni di Piansano, Arlena e Tessennano.
E questo grande impegno di territorio è comunque avvenuto, nonostante la Provincia di Viterbo sia scarsamente energivora, una delle meno energivore del Lazio. Inoltre il Lazio è la seconda regione d’Italia per potenza prodotta da impianti fotovoltaici a terra.
(cfr. http://www.fotovoltaicosulweb.it/guida/installare-un-impianto-fotovoltaico-in-un-areaagricola.html).
Andare oltre, con impianti della portata di Pian di Vico, significherebbe uno stravolgimento definitivo degli equilibri culturali, agricoli-produttivi, sociali-identitari, immobiliari e turistici del Lazio e nello specifico della Maremma Viterbese, resi fin troppo labili dall’ondata fotovoltaica ed eolica già verificatasi sul territorio nonché dalle ormai “storiche” servitù costituite dalle due grandi e inquinanti centrali termoelettriche di Civitavecchia e Montalto che, oltre ad aver provocato danni alla salute dei residenti, hanno pregiudicato e inibito lo sviluppo turistico della costa alto-laziale. Uno sviluppo turistico che, com’è noto negli ultimi decenni, aveva trovato proprio del pregiato entroterra il suo spazio vitale, che tuttavia, la trasformazione industriale del territorio, irrimediabilmente provocata dai nuovi progetti fotovoltaici ed eolici, potrebbe cancellare in modo definitivo.
Peraltro non ci risulta che dagli organi che hanno autorizzato l’impianto di Pian di Vico e che sono in procinto di autorizzare in parte o in toto altri progetti depositati in Regione, sia pervenuto alla cittadinanza uno studio che escluda eventuali rischi legati all’inquinamento elettromagnetico conseguente all’enorme diffusione, già oggi ingente e che per forza di cose è destinata ad aumentare ulteriormente, di cavidotti interrati ed elettrodotti e di altre opere legate agli impianti energetici.
Per operare scelte consapevoli, gli organi regionali dovrebbero quindi prendere in considerazione non soltanto gli effetti a ogni livello dei singoli impianti bensì anche quelli provocati dal “cumulo” dei complessivi impianti, laddove autorizzati.
Le considerazioni finora mai attuate dalla Regione Lazio hanno portato, in alcuni territori a tradizionale vocazione agricola – come ad esempio Civita Castellana e Montalto di Castro – ad un’anomala concentrazione di impianti fotovoltaici, principale causa della repentina trasformazione degli ambienti rurali in ambienti industriali.
Riteniamo che uno sviluppo davvero “sostenibile” del territorio regionale non possa essere agevolato tramite così radicali e rapide trasformazioni di vocazioni secolari o addirittura millenarie, spesso ben mantenute con precise scelte politiche da parte delle comunità locali.
Inoltre non riteniamo accettabile che cambiamenti così drastici, o meglio “epocali”, vengano autorizzati senza prima garantire il sufficiente e appropriato bagaglio di informazioni alla popolazione e senza prima coinvolgere quest’ultima in un dibattito pubblico finalizzato a una sua esplicita dichiarazione di consenso o diniego ai cambiamenti che – se effettuati – inciderebbero gravemente sulla vita dell’intera collettività, spesso con impatti sovracomunali ed irreparabili.
Ad opporsi in maniera decisa anche il Ministero per i Beni e Attività Culturali – Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha comunicato (nota prot. n. 7287 dell’11 marzo 2019) di aver proposto formale opposizione (art. 14 quinques, comma 1°, della legge n. 241/1990 e s.m.i.) davanti al Consiglio dei Ministri avverso la determinazione del 6 febbraio 2019 “con la quale la Regione Lazio, disattendendo i pareri negativi espressi dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha concluso positivamente la procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto” di realizzazione di un “Impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 150 MWp connesso alla RTN”, proposto dalla società energetica romana DCS s.r.l., in località Pian di Vico, nel Comune di Tuscania(VT).
Assotuscania, Italia Nostra, Forum Ambientalista, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, Legambiente, LIPU – BirdLife Italia

per visualizzare foto dell’area del comune di Tuscania interessata dai progetti: http://www.exploretuscia.com/tuscania-area-destined-to-energy-sprawl/

(foto Comitato Valle del Mignone, M.F., S.D., archivio GrIG)